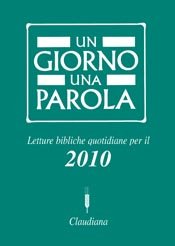 «Esprimendoci senza mezzi termini, non diremo che Dio sia conosciuto là dove non c'è né religione né pietà» scrive Calvino all'inizio dell'Istituzione, nel libro I, capitolo 2, paragrafo 1. Egli cioè sostiene che per conoscere Dio è necessaria una certa misura di «religione» e di «pietà» - due parole che nel Cinquecento avevano più o meno lo stesso significato che hanno nel nostro tempo. Succede però che proprio queste due parole oggi non sono gran che popolari nei nostri ambienti, anzi sono in disuso, per non dire che sono piuttosto screditate. Nei decenni scorsi ci è stato detto e ripetuto che non bisogna confondere e soprattutto non identificare fede e religione. Infatti la fede cristiana può esprimersi in termini laici, a esempio amando Dio e il prossimo, senza che questo amore assuma necessariamente forme religiose: ci può dunque essere fede senza religione. Inversamente ci può anche essere religione senza fede, ogni volta che (il caso è abbastanza frequente) la religione è dettata non dalla fede, ma dalla paura, o dalla superstizione, o da una visione magica del mondo, o semplicemente dall'abitudine, cioè dal pigro conformarsi a una tradizione. Già i profeti di Israele ci hanno messo in guardia rispetto a una religione senza fede: attraverso Osea, a esempio, Dio dichiara: «Io amo la pietà e non i sacrifici, e la conoscenza di Dio anziché gli olocausti» (6, 6). La pietà e la conoscenza di Dio sono la fede, i sacrifici e gli olocausti sono la religione. Gesù, parlando della sua generazione, afferma, citando Isaia: «Questo popolo mi onora con le labbra [cioè pratica la religione], ma il suo cuore è lontano da me [cioè non crede in me]» (Matteo 15,8). «Esprimendoci senza mezzi termini, non diremo che Dio sia conosciuto là dove non c'è né religione né pietà» scrive Calvino all'inizio dell'Istituzione, nel libro I, capitolo 2, paragrafo 1. Egli cioè sostiene che per conoscere Dio è necessaria una certa misura di «religione» e di «pietà» - due parole che nel Cinquecento avevano più o meno lo stesso significato che hanno nel nostro tempo. Succede però che proprio queste due parole oggi non sono gran che popolari nei nostri ambienti, anzi sono in disuso, per non dire che sono piuttosto screditate. Nei decenni scorsi ci è stato detto e ripetuto che non bisogna confondere e soprattutto non identificare fede e religione. Infatti la fede cristiana può esprimersi in termini laici, a esempio amando Dio e il prossimo, senza che questo amore assuma necessariamente forme religiose: ci può dunque essere fede senza religione. Inversamente ci può anche essere religione senza fede, ogni volta che (il caso è abbastanza frequente) la religione è dettata non dalla fede, ma dalla paura, o dalla superstizione, o da una visione magica del mondo, o semplicemente dall'abitudine, cioè dal pigro conformarsi a una tradizione. Già i profeti di Israele ci hanno messo in guardia rispetto a una religione senza fede: attraverso Osea, a esempio, Dio dichiara: «Io amo la pietà e non i sacrifici, e la conoscenza di Dio anziché gli olocausti» (6, 6). La pietà e la conoscenza di Dio sono la fede, i sacrifici e gli olocausti sono la religione. Gesù, parlando della sua generazione, afferma, citando Isaia: «Questo popolo mi onora con le labbra [cioè pratica la religione], ma il suo cuore è lontano da me [cioè non crede in me]» (Matteo 15,8).
È dunque vero che non bisogna confondere né identificare fede e religione. Ma non bisogna neppure separarle, e tanto meno contrapporle. Fede e religione possono darsi la mano: la fede deve ispirare la religione e renderla autentica, cioè sincera, intima, vera, e dal canto suo la pratica religiosa (come può essere, a esempio, la lettura personale della Bibbia, la frequentazione del culto domenicale e dello studio biblico settimanale) aiuta la fede a non deperire e forse morire, ma anche a non fossilizzarsi e non crescere mai.
Lo stesso discorso si può fare per la parola «pietà», che raramente viene illustrata e raccomandata dai nostri pulpiti e nelle nostre assemblee, quasi fosse qualcosa di disdicevole. Ho cercato la parola piété (= pietà in francese) nella Encyclopédie du Protestantisme (2a edizione 2006), ma, con mio vivo disappunto, non l'ho trovata. C'è la parola piétisme (= pietismo), ma non la parola piété. È una lacuna vistosa ed eloquente. Rivela il nostro imbarazzo verso questa parola, come se su di essa preferissimo tacere, mentre nei suoi confronti Calvino non provava nessun imbarazzo. Può darsi che inconsciamente la associamo al «pietismo», appunto, che, in generale, non gode di buona fama tra i protestanti odierni «teologicamente corretti», mentre in realtà, pur con i suoi limiti evidenti (messi in luce da Barth e altri nella sua scia), è stato uno dei periodi più fecondi della storia del protestantesimo: è il pietismo che ha creato un gran numero di opere sociali (molte tuttora attive) e che ha dato vita alle società missionarie.
E comunque Calvino non era un pietista, ma amava e praticava la pietà. La quale non è, come qualcuno pensa, la forma infantile della religione che un cristiano adulto ovviamente abbandona, ma è semplicemente il modo cultuale di esprimere la fede in Dio, amandolo e servendolo anche così. Certo, lo sappiamo bene, ci sono anche altri modi di amare e servire Dio: c'è soprattutto il servizio di Dio reso servendo l'uomo, nelle tante forme, principalmente laiche, che esso può assumere. Ma resta vero quello che dice Calvino, e cioè che non ci può essere conoscenza di Dio là dove non c'è nessuna forma di religione e di pietà.
Una di queste forme, come già s'è detto, è la lettura personale, possibilmente quotidiana, della Bibbia che è, per ogni cristiano, e più che mai per un protestante, l'atto fondativo della sua esistenza di fede. Infatti, come disse Karl Barth in una celebre conferenza del 1922: «La Riforma ci ha tolto tutto e, crudelmente, ci ha lasciato solo la Bibbia». Come dire: O la Bibbia o nulla. O ti aggrappi alla Bibbia, oppure, come cristiano, fai spiritualmente naufragio. O la fede si nutre della Parola di Dio, oppure si ammala di una delle numerose malattie che la minacciano. E come il nostro corpo dev'essere nutrito ogni giorno, se vuole vivere e restare in salute, così accade all'anima: lontano dalla Parola di Dio si atrofizza e diventa più apparente che reale. Per assecondare la lettura della Bibbia e farne un appuntamento quotidiano, la Claudiana pubblica ogni anno il lezionario biblico Un giorno, una parola. È uscito quello del 2010 e vi aspetta in libreria (*). Fatevi questo regalo: costa poco e vale molto. Regalatelo ad amici e conoscenti, parenti e colleghi di lavoro o altro: è un piccolo grande dono che non solo dura tutto l'anno, ma che, soprattutto, può aprire la strada a un dono infinitamente più grande: quella conoscenza di Dio, che non ci può essere senza qualche forma di pietà e di religione.
__________________________
(*) Questo Lezionario è pubblicato ininterrottamente dal 1731 a cura della Comunità dei fratelli Moravi, fondata dal conte Ludwig von Zinzendorf (1700-1760: un pietista di terza generazione!), che accolse sulle sue terre dei profughi evangelici cacciati dalla Moravia per motivi di fede. L'edizione del 2010 è la 280a della serie. Tradotto in 52 lingue, è diffuso ogni anno in due milioni di copie. L'edizione italiana contiene anche una Introduzione su «La Bibbia nel movimento ecumenico: 1910-2010» e 12 tavole a colori che riproducono una serie di bellissimi affreschi della Scuola senese del XIV secolo, situati nel monastero benedettino detto del «Sacro Speco», a Subiaco, in provincia di Roma. Il Lezionario costa 10 euro.
Tratto da Riforma del 4 dicembre 2009 |
